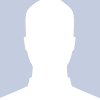Menu
UdR ROMA TRE
PRIN ROMA TRE
TITOLO DEL PROGRAMMA
La qualità nell’alta formazione. Modelli di elaborazione curricolare e controllo dei processi formativi
PAROLE CHIAVE
Qualità, Alta Formazione, Modelli, Metodologie, Valutazione, Ricerca, Società della Conoscenza
COORDINATORE SCIENTIFICO
ALESSANDRINI Giuditta - Prof. Ordinario di Pedagogia sociale e del lavoro. Direttore Master GESCOM
COMPONENTI UDR
BRUNI Franco – Ricercatore MUR e cultore di materia
CUCCHI Patrizia - Docente
DELL’OLIO Corrado – Dirigente scolastico e cultore di materia
FIORUCCI Massimiliano – Professore associato
ISOPI Antonella – Dirigente scolastico e cultore di materia
PIGNALBERI Claudio – Collaboratore di ricerca e e-tutor Master post-laurea
VOLPI Stefano – Esperto politiche valutative ISFOL
Il paradigma della “società della conoscenza”, l’affermarsi di processi di divisione del lavoro orientati da logiche proprie del post-fordismo e gli scenari della post-modernità sono i tre assi che – nella loro complessità ed interdipendenza – proiettano nuove significazioni dell’universo di discorso dell’Alta Formazione.
Il concetto di società della conoscenza è stato ripensato con sistematicità e coerenza, ma anche rilanciato come “visione del mondo” dei paesi europei su cui si trattava di pilotare gli obiettivi di sviluppo.
A Lisbona, nel marzo 2000, in occasione del Summit – in continuità con altre tappe importanti di un percorso di elaborazione progressiva – sono stati definiti una serie di indirizzi basilari per le politiche dei paesi membri che successivamente sono stati tradotti in un documento più pragmatico ad effettivo uso di coloro che per professione si occupano di educazione e formazione, il Memorandum. Per la prima volta, dunque, nel documento di Lisbona il consiglio ha posto in termini chiari e decisi il problema di creare le condizioni per il cammino verso una società della conoscenza, nella duplice valenza di investimento nella crescita dell’informatizzazione di massa e un’equa “riequilibratura” delle opportunità di formazione per tutte le categorie sociali.
Alla strategia di Lisbona si accompagna il cosiddetto “processo di Bologna” relativo al sistema della formazione universitaria e si collega, infine, il lento cammino della firma della Costituzione europea, siglata a Roma il 29 ottobre 2004. Il processo di Bologna, sviluppando in un’ottica di armonizzazione europea l’impianto di cicli di alta formazione aperti e flessibili che si innestano nell’idea del “life long learning” (apprendimento durante tutto l’arco della vita), favorisce l’idea dell’accesso, l’idea di una mobilità che si traduca in strumento di equità.
E’ opportuno evidenziare le sette dimensioni significative che caratterizzano il tema del rapporto tra formazione e lavoro nella “società della conoscenza”. Le dimensioni sono strettamente correlate, ma l’elemento più interessante per chi elabora alta formazione è che le aree sottolineate nella tavola possono essere interpretate come aree di progettualità.
Sette dimensioni-chiave della società della conoscenza nell’elaborazione di Lisbona
1. Dematerializzazione dell’economia;
2. Focalizzazione sugli investimenti nell’informatizzazione digitale e nella facilitazione dell’accesso alla conoscenza;
3. Primato delle strategie di inclusione sociale;
4. Affermazione del paradigma dell’occupabilità;
5. Focus sull’integrazione tra sistemi formativi;
6. Focalizzazione sui sistemi di competenze e sull’armonizzazione delle qualifiche;
7. Complementarità degli apprendimenti formali ed informali per lo sviluppo delle persone.
È aumentata la complessità degli scenari di lavoro rispetto a cui si rivolge l’alta formazione: ciò implica modalità diverse di porsi per i decisori, nuove sensibilità, ma soprattutto un approccio diverso di progettazione.
Per esempio, un’attenzione di tipo “territoriale” alla leva formativa. Il territorio va visto – in coerenza con una moderna visione delle dimensioni economico-sociali di tipo sistemico – come l’insieme degli elementi che su di esso insistono e delle relazioni intercorrenti tra tali elementi. L’università e le altre agenzie di alta formazione, ad esempio, deve essere un soggetto che agisce nell’assetto istituzionale che definisce ed integra tali elementi grazie allo svolgimento di compiti di formazione e di ricerca in grado di diffondere quella conoscenza che è la base dello sviluppo dei sistemi locali. I processi di accumulazione della conoscenza teorica ed applicata, di creazione del capitale umano, di diffusione e trasferimento dell’innovazione tecnologica (spin-off) e di apprendimento collettivo hanno infatti un carattere che si coniuga secondo dimensioni che hanno una specificità di tipo territoriale.
Il territorio è anche Pubblica Amministrazione centrale e locale e, come si legge nel secondo Memorandum, “la politica regionale di coesione comunitaria deve ulteriormente rafforzare il sostegno ai processi di modernizzazione delle istituzioni pubbliche”.
Anche il sistema universitario deve impegnarsi nel prossimo futuro per attivare, promuovere o consolidare reti formative tra i soggetti attori del sistema locale, incrementando il patrimonio cognitivo già sviluppatosi e catalizzando nuove risorse, nella comune convinzione che l’apertura al contesto territoriale sia uno strumento per valorizzare il ruolo del sistema formativo come risorsa strategica per lo sviluppo del paese.